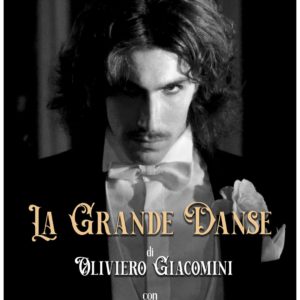Action Academy ama gli attori, li segue, li studia ed anzi, tanto per gli studenti del Corso di recitazione che per quelli di Creatività e Produzione lo studio delle performance recitative di alcuni grandi nomi del panorama nazionale e sovranazionale è diventato uno strumento didattico di importanza primaria. Lo studio mirato della micro-mimica facciale, anche procedendo frame by frame, per analizzare le possibili significazioni emozionali che l’attore professionista riesce a manifestare semplicemente modificando pochi significativi tratti del suo volto plastico, l’analisi semantica della voce attoriale alla ricerca di quelle modulazioni del timbro, del tono e del volume che manifestano il fluire ininterrotto delle emozioni del personaggio, ma anche l’analisi e la riflessione critica sulle dichiarazioni di poetica e i testi prodotti da registi e attori di indiscussa fama e capacità artistica, che permetta a questi ragazzi di confrontare la propria idea di cinema, di recitazione o regia con quella di chi già si è affermato, affermando al contempo la propria idea vincente di cinema. È in questo contesto di studi mirati alla consapevolizzazione della pratica attorica che questa settimana ho proposto ad alcuni studenti del corso di recitazione di riflettere su una importante dichiarazione rilasciata dall’ormai mitico Pierfrancesco Favino relativamente al suo modo di intendere la speciale relazione che si instaura fra attore e personaggio. Qui di seguito condivido con voi le riflessioni di una delle nostre giovani attrici, Caterina Meniconi, che a partire dalla frase del Pierfrancesco nazionale ha sputo elaborare un percorso di riflessione sul senso del recitare estremamente personale e non scontato nelle conclusioni,
buona lettura.
Il mestiere dell’attore è da sempre oggetto di discussione, fascinazione e curiosità. Nei secoli la sua figura ha visto una progressiva legittimazione ed è indubbio che in ogni epoca la sua metamorfica presenza sia stata imprescindibile dal contesto sociale e politico del tempo.
Con lui, anche le sue tecniche si sono evolute, seppure non sempre in accordo. Talvolta la tecnica rincorreva l’attore, talaltra l’attore faticava a stare dietro alle nuove sperimentazioni e il ‘900 è stato sicuramente il secolo che maggiormente ha sviscerato e stravolto l’essere attore, o più precisamente, l’essere e l’attore.
Pierfrancesco Favino, reduce da un trionfo a Venezia che l’ha visto aggiudicarsi la Coppa Volpi per la sua interpretazione in “Padrenostro”, sul mestiere dell’attore ha detto:
«Entrare nel personaggio? Non si entra da nessuna parte: il personaggio è solo un pezzo della storia ed è al suo servizio. Noi attori possiamo solo ospitarlo, il personaggio che interpretiamo. Ed essere un gancio per l’immaginazione dello spettatore. Non possiamo mai smettere di essere noi stessi, non foss’altro perché abbiamo una faccia, un corpo e una vita nostri. Io posso mettere le mie intere capacità a disposizione della comprensione sensoriale e psichica di quella che potrebbe essere la vita di chi interpreto. Sa, nella sua forma più alta questo mestiere significa mettersi totalmente al servizio degli altri. Spesso chi comincia a fare l’attore lo fa per il desiderio di essere amato, ma con il tempo si capisce che la prospettiva va ribaltata: lo si fa non per ricevere, ma per dare…».

Nessuna magia, quindi, nessuna tecnica segreta che trasformi il sé in altro da sé, solo qualcuno che per un limitato lasso di tempo si trova ad ospitare qualcos’altro, rendendolo reale agli occhi di chi guarda. Riduttivo e decisamente poco poetico; a Favi’ perché c’hai voluto toglie’ a maggia dell’attore? Questo viene da pensare, lo so, e anche a me che attrice lo sono, lo faccio, lo vivo, lo tutto, all’inizio questa sua affermazione ha fatto storcere il naso – credetemi, l’ho dovuta rileggere più e più volte per trovarci una mia verità, fino a quando ho avuto la mia personale epifania.
Punto primo: l’attore non è attore, lo fa. Se tutti coloro che aspirano ad esserlo avessero tale consapevolezza, la categoria si ridurrebbe di brutto, rendendolo un contesto molto meno affollato.
Nessun sacro fuoco ottocentesco a guidare le nostre membra verso una macchina da presa, ragazzi, il mestiere dell’attore è tale come quello del dottore, lo si impara, lo si studia, lo si esperisce quotidianamente. Siamo atleti delle emozioni e come tali abbiamo il dovere di allenarci giorno dopo giorno. Se non lo facciamo, siamo amatoriali presi dalla passione, legittimi, ma non ascrivibili al professionismo.
Amare la recitazione, sentire la necessità di esprimere se stessi attraverso la storia di qualcun altro è il primo passo, è vero. Avvertiamo quel guizzo dentro, lo percepiamo come “il sogno”, siamo votati ad aprire la voragine emozionale e a vivere il monologo assegnatoci, e via di “mi sono emozionato a farlo”, “ho lasciato fluire le emozioni”, tutto molto emozionante, e purtroppo assai ripetitivo. Emozione, emozione, emozione. Avere tante emozioni è parte dell’essere umano, non fa di noi degli attori, è una dotazione di serie e, chi più chi meno, ce l’abbiamo tutti.
Riconoscere le emozioni, plasmarle, evocarle, concretizzarle in gesti, suoni, parole, pause, espressioni, pensieri, movimenti, tocchi, ecco tutto questo inizia a essere più simile a quello che un attore fa, ma ancora non siamo vicini all’obiettivo, perché seppure mestiere a tutti gli effetti, fonda la sua manifestazione su strumenti labili, mutevoli e molto spesso difficilmente conoscibili: noi, gli esseri umani.
E credo sia proprio in funzione di questo che l’essere attore abbia subito una sorta di fraintendimento. Se prima del ‘900 molto del suo lavoro era ascrivibile a tecniche fisiche, vocali e mimiche, al limite dello stereotipo (generalizzando è chiaro, ma siate clementi) in seguito, l’avvento della psicanalisi e la scoperta di un universo interiore prima mai veramente esplorato ha ribaltato la situazione. L’interiorità si è imposta nel mondo come nuova frontiera di ascolto e conoscenza umana, andando a invadere prepotentemente il mestiere dell’attore che, come abbiamo detto, è sempre in linea col tempo e la società che si trova a vivere in quel dato momento.

Tali nuove consapevolezze, però, se in un primo momento sono andate in qualche modo a sommarsi alle altre, progressivamente si sono imposte come uniche linee guida, finendo col divenire quelle preminenti in molti contesti.
Se nel teatro ancora resistono derive di questa crasi, nel cinema e nella televisione, dove la macchina da presa permette una frammentazione del corpo attoriale tale da rendere visibile il dettaglio di uno sguardo, molto dell’attore è stato rimandato alla sola sfera emozionale, quantomeno nell’immaginario collettivo.
L’attore è colui che vive il personaggio, che trasmette, che si emoziona ed emoziona, e da qui molti aspiranti attori credono che tutto sia da rimandare a quanta sensibilità abbiano, al dolore “reale” che stanno vivendo, all’onda emotiva su cui si muovono proferendo parola.
Favino, in questo senso, vuole a mio avviso rimettere le cose al proprio posto, conferendo nuova legittimità a un qualcosa che mestiere lo è a tutti gli effetti e che questo tolga o meno magia al nostro lavoro poco importa.
Ovvio che ogni attore, avendo come strumento il proprio sé, avrà delle specifiche che nessun altro potrà manifestare. Ospitare il personaggio in noi implica mettersi al servizio di un’idea, di un pensiero, che grazie alle nostra unicità può finalmente divenire reale.

Viviamo ciò che sente, sì, lo evochiamo, ognuno con la tecnica che più predilige; siamo in grado di amare qualcuno che non abbiamo mai visto (santa tecnica della sostituzione!), di odiare, di uccidere, di impazzire e ridere, ed è vero che in alcuni momenti molto di noi è travolto da questo profluvio di emozioni, ma resiste un margine di controllo, sempre.
La mente sta, la razionalità da qualche parte resta e si presta a dirigere ciò che le emozioni andrebbero a caotizzare. Noi attori viviamo il personaggio fra sogno e realtà: una parte è lanciata a grande velocità verso luoghi a volte inaspettati, ma alla guida abbiamo sempre il sé presente, e dirò di più, dobbiamo averlo, altrimenti faremmo un torto alla storia e al suo manifestarsi nella realtà.
Se non avessimo controllo, come potremmo, nel mentre di una scena fortemente emozionale, andare nel punto esatto in cui la luce dovrà illuminarci, o sul segno posto sul set perché la macchina da presa possa inquadrarci a fuoco?
Quindi davvero nessuna magia?
Oh, sì che c’è… ma è diversa per ognuno. Potrei dirvi dove si nasconde la mia, ma poi dovrei uccidervi.